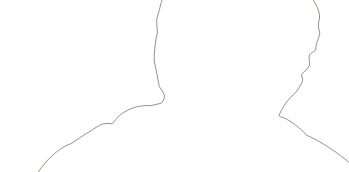|
Sempre a proposito di marchette. Sul settimanale "Tempi" del 12 aprile 2007 compare il seguente articolo di Paolo Bracalini, che riporta gentilmente anche una mia dichiarazione. Il titolo è "Zerbini pret-à-porter".
«PRONTO? SONO UN GIORNALISTA, mi chiamo pinco pallino, posso parlare con l’ufficio stampa? È per un’intervista a Stefano Gabbana». «Lei chi è?», acidissima. Dopo la ripetizione delle generalità la telefonata con la segreteria di D&G prosegue sul filo dell’isteria, così è la norma, mi diranno poi. Dopo inutili spiegazioni ti informano che non muovono un mignolo, perché tutto deve essere preceduto da un fax con la richiesta ufficiale di un’intervista, dove, chi, quando, come e perché, in carta intestata. Scrivi dove, chi, quando, come e perché e mandi il fax. Richiami. Il fax non è arrivato. Altra dose di acido solforico al telefono. Altro fax. Servono almeno cinque tentativi per parlare con l’ufficio stampa, due signore temutissime. Che ti danno regolarmente il due di picche. «Parlano solo con quelli di cui si fidano», mi spiegheranno più avanti. Per meglio dire, solo cronisti già rodati nell’arte del ricamo. È la stampa vista e vestita dalla moda, l’informazione prêt-à-porter secondo i fashion leader. E la stampa, va detto, indossa volentieri l’abito disegnato dai capricci dei maestri dello stile. Domenico Dolce e Stefano Gabbana sono i campioni del genere.
Abituati a leggere sui giornali di moda (e non solo) quello che loro scriverebbero di se stessi, grazie a uno stuolo di croniste adulanti, non tollerano recensioni negative.
Critica gastronomica e scrittrice, Camilla Baresani si occupa di ristoranti per il supplemento domenicale del Sole 24 Ore. Per sua disgrazia ha recensito quello di D&G a Milano, trovando che la cotoletta del famoso Gold fosse «la peggiore mai mangiata». La coppia ha reagito con rara eleganza. Invece di prendersela con il proprio chef ha preferito concentrarsi sulla giornalista. I due hanno minacciato di ritirare tutta la pubblicità sul Sole 24 Ore e in un’intervista tv hanno definito «una stronza» la giornalista che si è permessa di fare il suo lavoro. Anzi, prima avevano cercato di spiegare la stroncatura, non avendola evidentemente mai vista in faccia, col fatto che fosse probabilmente «grassa e frustrata». Magistri elegantiae. Finita qui? No. Perché la cosa più inquietante è che due settimane dopo lo stesso domenicale del Sole 24 Ore ha ri-recensito lo stesso locale, cosa alquanto insolita, trovandolo questa volta magnifico.
Un’altra disavventura con la suscettibilità isterica dei designer di moda è capitata a Cathy Horyn, inviata del New York Times per le sfilate di Milano lo scorso febbraio.
Ha scritto che certi pantaloni della collezione Giorgio Armani le sembravano «da jogging», e lui come risposta le ha impedito l’ingresso al defilè: «Lei ha il diritto di scrivere, io di lasciarla fuori. C’è il diritto di critica, non di idiozia», sintesi suprema del concetto di libertà di opinione secondo gli stilisti.
Certo li capiamo. Grandi inserzionisti, si aspettano che la stampa li ricambi vezzeggiandoli. E possiamo capire anche certi colleghi, la tentazione di passare alla marchetta deve essere fortissima in quel campo. Viaggi gratis, vacanze in beauty farm pagate dalle case di moda, cene vip, regali. La categoria, già tendente al cialtrone per sua natura, davanti al lusso si incialtronisce ancor di più.
Così la critica finisce per apparire, agli stilisti, solo un virus da debellare. «Si è creato un rapporto simbiotico tra certa stampa e le grandi case di moda – spiega il pubblicitario Lillo Perri, storico fondatore di “Pubblicità Italia” –. Gli stilisti pensano di poter decidere tutto, senza doversi sottoporre ad un giudizio esterno, in una maniera ormai del tutto autoreferenziale. È un mondo che vive solo di immagine e non di prodotto, è distaccato dalla realtà. Per questo capita che chi critichi una loro griffe possa subire una reazione violenta».
Ma in questo modo il passo dall’eleganza alla volgarità è breve. L’evoluzione della pubblicità di Dolce & Gabbana ne è un esempio. Dalle atmosfere ambigue, siculobarocche dei primi spot, il duo è passato alle perversioni sadomaso sacrificando ogni originalità al feticcio ben più remunerativo della cosiddetta “trasgressione”.
Dall’eleganza alla volgarità.
Per esempio, il peto che suggella il duetto tra due fidanzati nella pubblicità D&G del 2004. Ma quello era buon gusto rispetto all’evoluzione successiva. Una donna sdraiata a terra, un uomo, a torso nudo, chino su di lei, le stringe i polsi impedendole qualsiasi movimento, con altri quattro che
guardano impassibili la scena. Una specie di anteprima di stupro collettivo. Trasgressivo? Forse solo cattivo gusto. In Spagna e in Italia questa pubblicità di Dolce & Gabbana è stata contestata e poi bloccata. Così in Inghilterra a gennaio l’Asa (Advertising Standards Authority) ha fermato un’altra campagna stampa dei due stilisti, che ritraeva un gruppo di modelli, in un’ambientazione napoleonica, che brandivano lame e armi, con personaggi feriti e uccisi per terra. Secondo certi esperti la provocazione sarebbe studiata apposta per incappare nella censura, trasformare tutta la polemica in un trionfo del trash e ricavarne un effetto promozionale di ritorno, maggiore di quello iniziale. Così come per Armani, che in Spagna è stato duramente criticato per una pubblicità di dubbio gusto: un’immagine in bianco e nero di due bambine orientali, truccate e vestite come donne. Perfette per ispirare i viaggi dei turisti del sesso in Asia. «La comunicazione degli stilisti ha scelto il registro della trasgressione – spiega Perri –, perché è una scorciatoia per raggiungere i teenager. Ma in questo modo si cade facilmente nella volgarità e nell’ineleganza».
Arroganti e ineleganti. Ma le griffe sono state viziate da una stampa sempre pronta all’inchino. Ne sa qualcosa Paolo Bianchi, scrittore e coautore insieme a Sabrina Giannini di un libro inchiesta, La Repubblica delle marchette (Stampa alternativa). «In certe testate c’è un rapporto di sudditanza verso inserzionisti importanti come le grandi case di moda. È anche vero che molti di questi giornali non sono nemmeno dei giornali, ma dei cataloghi pubblicitari, studiati sulla base della raccolta pubblicitaria. Da tutto ciò deriva una perdita di credibilità dei giornali, anche se il lettore è spesso abbastanza inerte, non riconosce la marchetta. Ammannisci qualunque piatto e il pubblico può anche digerirlo».
Magari anche una cattiva cotoletta.
Paolo Bracalini
|